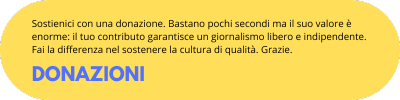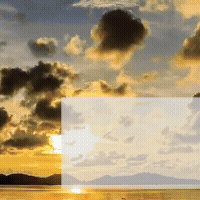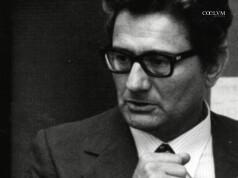Le prime immagini del Vera C. Rubin Observatory sono state finalmente svelate, e il mondo dell’astronomia entra ufficialmente in una nuova era. Con vedute mozzafiato delle nebulose Laguna e Trifida, dell’ammasso di galassie della Vergine, e di una straordinaria quantità di stelle, galassie e asteroidi, l’osservatorio installato sulle Ande cilene ha dato un assaggio delle sue straordinarie potenzialità. È l’inizio della Legacy Survey of Space and Time (LSST), il più ambizioso programma di mappatura astronomica mai concepito.

Credit: H.Stockebrand/RubinObs/NOIRLab/SLAC/DOE/NSF/AURA
Situato a oltre 2.600 metri di altitudine sul Cerro Pachón, in Cile, e frutto di una collaborazione tra la National Science Foundation (NSF) e il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), il Rubin Observatory ha mostrato al mondo ciò di cui è capace. In meno di dieci ore di osservazione, il telescopio ha già catturato una ricchezza di dettagli celesti: dalle nebulose della costellazione del Sagittario — Laguna a circa 4.000 anni luce e Trifida a circa 5.000 — all’ammasso della Vergine, distante oltre 60 milioni di anni luce, fino a una moltitudine di oggetti del nostro Sistema Solare.
“Rubin ci consente di aggiungere profondità e dinamismo all’osservazione dell’Universo”, ha dichiarato Roberto Ragazzoni, presidente dell’INAF, l’Istituto Nazionale di Astrofisica italiano, partner del progetto. “Con la sua capacità di mappare l’intero cielo australe ogni tre giorni, entriamo nell’epoca dell’astro-cinematografia”.
Un telescopio rivoluzionario
Il cuore tecnologico dell’osservatorio è la più grande fotocamera astronomica mai costruita, con una risoluzione di 3.200 megapixel. Ogni sua immagine copre un’area del cielo pari a 45 volte la Luna piena, e per visualizzarla in tutta la sua risoluzione sarebbero necessari ben 400 schermi 4K. Grazie a un sistema di puntamento ultrarapido, Rubin potrà osservare ogni angolo del cielo australe in appena 3-4 notti, accumulando nel corso di un decennio circa 800 osservazioni per ciascuna regione celeste.
“È una vera e propria pellicola multicolore dell’Universo in divenire”, ha commentato Rosaria Bonito, astrofisica INAF e rappresentante italiana nel board della LSST Discovery Alliance. “Rubin cambierà radicalmente il nostro modo di fare astrofisica: osservazioni ad alta cadenza temporale permetteranno di studiare fenomeni transienti, esplosioni stellari, variabilità, e oggetti dinamici come asteroidi o comete, con un dettaglio senza precedenti”.

Un progetto globale, anche italiano
L’Italia partecipa al progetto Rubin dal 2017 attraverso l’INAF, che svolge un ruolo chiave nell’analisi e gestione dei dati. Ogni notte, l’osservatorio genererà circa 20 terabyte di dati, ponendo sfide senza precedenti in termini di archiviazione, elaborazione e interpretazione scientifica. I ricercatori italiani sono coinvolti sia nello sviluppo degli strumenti di analisi che nell’ottimizzazione delle strategie osservative.
L’approccio interdisciplinare del progetto coinvolge modelli teorici, intelligenza artificiale, scienza dei dati e cooperazione internazionale. Grazie a questa sinergia, Rubin potrà affrontare alcune delle grandi questioni ancora aperte della cosmologia moderna: la materia oscura, l’energia oscura, la formazione delle galassie, l’archeologia stellare e la sorveglianza degli oggetti potenzialmente pericolosi per la Terra.
Una missione in onore di Vera Rubin
L’osservatorio prende il nome da Vera C. Rubin (1928–2016), l’astrofisica statunitense che per prima fornì prove convincenti dell’esistenza della materia oscura attraverso lo studio della rotazione delle galassie. Rubin è anche ricordata per il suo impegno nel promuovere la presenza delle donne nella scienza. L’eredità di Vera Rubin vive oggi nelle migliaia di ricercatori che lavoreranno con i dati del telescopio che porta il suo nome.
Una finestra sul cielo in movimento
Tra gli obiettivi prioritari del Rubin Observatory figura lo studio delle stelle variabili, la cui luminosità cambia nel tempo. Grazie alla sua eccezionale precisione fotometrica, Rubin permetterà di studiare oltre 100 milioni di questi oggetti, rivelando i meccanismi interni delle stelle e i fenomeni esterni come eclissi da parte di pianeti o compagni stellari.
Inoltre, il telescopio sarà in grado di catturare in tempo reale milioni di esplosioni stellari, inclusi eventi rari e luminosi come le supernove di tipo Ia, utilizzate per misurare l’espansione dell’universo e svelare il ruolo dell’energia oscura.
“Se qualcosa nel cielo si muove o cambia, Rubin lo vedrà”, ribadisce Bonito. “E lo renderà disponibile alla comunità scientifica mondiale in tempo reale”.
Un primo sguardo che lascia senza parole
Le immagini presentate oggi — trasmesse in diretta durante eventi pubblici in tutto il mondo, inclusa la Sala Piersanti Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo — sono solo l’inizio. Quelle che ora possiamo ammirare sono le prime sequenze di una narrazione visiva dell’universo che si estenderà per i prossimi dieci anni. Una narrazione fatta non più di singoli fotogrammi, ma di sequenze temporali in alta definizione, capaci di restituire il cosmo nella sua dinamica, nella sua complessità, e nella sua stupefacente bellezza.



In appena 10 ore di osservazioni, il Vera C. Rubin Observatory, finanziato da NSF e DOE, ha individuato 2.104 asteroidi mai osservati prima nel nostro Sistema Solare, inclusi sette asteroidi vicini alla Terra, che non rappresentano alcuna minaccia.
Per confronto, tutti gli altri osservatori terrestri e spaziali nel mondo scoprono complessivamente circa 20.000 asteroidi l’anno. Da solo, il Rubin Observatory è destinato a scoprire milioni di nuovi asteroidi nei primi due anni della Legacy Survey of Space and Time (LSST).
Inoltre, sarà l’osservatorio più efficiente al mondo nell’individuazione di oggetti interstellari in transito attraverso il Sistema Solare.
Credito: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory
Fonte: http://rubinobservatory.org/news/press-releases