I manoscritti di Leonardo sono ricchi di riferimenti a problemi di ottica e di teoria della visione. Il motivo principale di questo suo spiccato interesse, che ritroviamo negli straordinari studi sull’anatomia e la fisiologia dell’occhio, deriva principalmente dalle sue ricerche sulla prospettiva e la pittura e solo marginalmente ha coinvolto altre discipline quali l’astronomia.
L’ottica ai tempi di Leonardo era un tortuoso groviglio di misteri che venivano spiegati con teorie assolutamente improbabili e contraddittorie. Fin dall’antichità era noto che la conoscenza del mondo esterno avveniva attraverso gli organi di senso, i quali comunicano con il cervello, sede della psiche, per mezzo di un complesso sistema di terminazioni nervose. L’odorato, il tatto e l’udito erano spiegati con meccanismi abbastanza plausibili, rimaneva però il senso della vista, il più difficile e complesso da interpretare.
Che “vedere” e percepire il “colore” fossero funzioni della psiche, che acquisiva le informazioni attraverso gli occhi, non era messo in dubbio da nessuno.
Ma ci si chiedeva: in che modo l’occhio svolge la sua funzione e come interagisce con il cervello?
Per avere la certezza che quello che si “vede” è reale (un paesaggio, il cielo stellato), è necessaria una forma di comunicazione tra l’oggetto ed il nostro sistema visivo. Sorge però una grave difficoltà: che cosa poteva entrare nell’occhio attraverso la “pupilla”, un piccolo foro che mediamente ha appena due millimetri di diametro, e conservare, integre, le informazioni che provengono dal mondo esterno?
Una prima teoria supponeva che da un oggetto del mondo reale partisse, ad ogni istante, una specie di “scorza”, sottilissima, eterea ed esattamente identica nella forma e nel coloro all’oggetto da cui è generata. L’insieme di queste impalpabili “scorze”, provenienti da oggetti diversi nel campo di vista, non dovevano interagire tra loro ma, allo stesso tempo, si dovevano contrarre per diventare così minuscole da potersi infilare nella pupilla. La spiegazione era talmente improbabile che nell’antichità non raccolse che pochi consensi. Un’ipotesi alternativa provenne dalle ricerche di prospettiva dei grandi matematici greci e latini che concepirono l’idea dei “raggi visuali”. I raggi visuali sono una sorta di bastoncini infinitamente sottili e rettilinei che vengono emessi dagli occhi dell’osservatore. L’esplorazione dell’ambiente attraverso questi raggi consente di portare agli occhi gli elementi che la psiche potrà poi interpretare come forme, posizione nella scena e colori degli oggetti. Questa teoria, benché non migliore della precedente, fu accettata per quasi 1500 anni.
Essa entrò in crisi quando, intorno all’anno Mille, l’arabo Alhazen fece un’osservazione assai comune, che però nessuno aveva mai prima segnalato: quella della “persistenza delle immagini sulla retina”.
Se guardiamo il Sole e poi chiudiamo gli occhi, continueremo a vederne l’immagine impressa nella retina per diversi minuti. I raggi visuali non giustificavano affatto questo fenomeno, pertanto la teoria non era sostenibile.
Alhazen ipotizzò allora una sostanziale modifica alla concezione delle “scorze”. Se un oggetto è costituito da un insieme di parti piccolissime, pressoché puntiformi, ognuna delle quali emette minuscole “scorze” che si propagano linearmente in ogni direzione, conservando la similitudine con il piccolo elemento che le ha emesse, allora esse potranno entrare senza difficoltà nella pupilla.
Ai tempi di Leonardo però, si continuava a parlare in via ipotetica di raggi visuali quando si argomentava di prospettiva e di “scorze” di Alhazen quando si tentava di giustificare il meccanismo fisiologico della visione. Le cose peggioravano drammaticamente quando l’obiettivo era di unificare, in un’unica teoria, prospettiva e visione: la mistura delle due concezioni generava autentici mostri.
Ne è un esempio la concezione secondo la quale dai corpi luminosi (il Sole, la fiamma di una candela..), doveva partire un non meglio definito “lumen”, capace di illuminare i corpi e a farne emettere delle scorze impalpabili, dette “specie” dotate della forma e dei colori dei corpi illuminati.
A conclusione di questa esposizione dell’ottica antica e medievale, dobbiamo dare atto che la teoria dei “raggi visuali”, nonostante le sue gravissime pecche teoriche, era stata applicata con un certo successo già da Euclide (III secolo a.C.) che se ne era servito per spiegare la riflessione della luce da parte degli specchi piani e concavi.
La rifrazione della luce, invece, mostrava difficoltà insormontabili. Soltanto Tolomeo, che aveva studiato la rifrazione atmosferica, ottenne qualche significativo risultato, senza però giungere ad una legge generale che fosse valida per angoli d’incidenza qualsiasi.
Quando poi nel XIII secolo apparvero le lenti di vetro per correggere la presbiopia, la teoria dei raggi visuali crollò, anche se i filosofi, per almeno i tre secoli successivi, non lo vollero ammettere. La qualifica “di vetro”, che si aggiungeva alla parola lente fu a lungo necessaria perché, altrimenti, il pensiero sarebbe subito corso a un bel piatto di lenticchie. Lenticchia, infatti, era il significato della parola lente, il che la dice lunga sull’ambiente dal quale scaturì l’uso che se ne fece per correggere i difetti visivi: quasi sicuramente esse furono create nelle botteghe vetrarie di Venezia e Firenze.
Qualche filosofo aristotelico non perse l’opportunità di esaminare questi strani dischetti curvi di vetro. Dopo che essi furono maneggiati e rimirati, ecco l’impietoso verdetto: le “lenticchie” producono effetti ingannevoli. Guardandoci attraverso, si vedono figure più grandi o più piccole di quelle reali, spesso capovolte, deformate e circondate da colori innaturali.
Dal punto di vista del filosofo è innegabile che le lenti possedevano inspiegabili proprietà “magiche”, tali da deformare la realtà. Alcuni decenni dopo la morte di Leonardo, il napoletano G.B. della Porta, in una sua opera intitolata, non a caso, Magia Naturalis, descriveva gli effetti dei sistemi ottici e delle lenti di ingrandimento, presentandoli però più come semplici curiosità al limite dell’illusionismo e della magia che a fenomeni coerenti con una teoria plausibile.






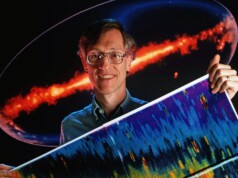








molto interessante!!!!!!