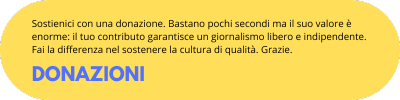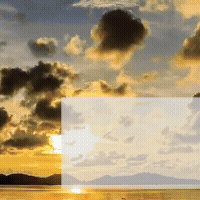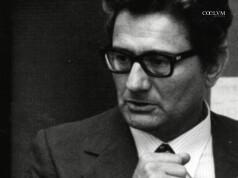Installata la fotocamera LSST da 3200 megapixel: al via la mappatura decennale dell’Universo dal Cerro Pachón in Cile.
di Gaëlle Suter
In cima al Cerro Pachón, nel nord del Cile, un progetto ventennale giunge a un momento storico: la fotocamera LSST (Legacy Survey of Space and Time), il più grande sensore digitale mai costruito per l’astronomia, è stata installata con successo sul telescopio Simonyi Survey del Vera C. Rubin Observatory. Con i suoi 3200 megapixel, la camera permetterà una mappatura senza precedenti dell’Universo, offrendo dati fondamentali per comprendere fenomeni come materia oscura, energia oscura e l’evoluzione cosmica.
Finanziato dalla National Science Foundation (NSF) e dall’Office of Science del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE), il progetto è gestito congiuntamente da NOIRLab e dal SLAC National Accelerator Laboratory, in collaborazione con oltre 40 enti scientifici internazionali.
Una fotocamera senza precedenti
Realizzata presso lo SLAC in California, la fotocamera LSST rappresenta un capolavoro di ingegneria scientifica. Composta da 189 sensori CCD, è progettata per acquisire immagini ad altissima risoluzione con una sensibilità tale da rilevare oggetti celesti debolissimi in tempi rapidissimi. Ogni esposizione sarà equivalente a una fotografia da 3200 megapixel, una capacità sufficiente a riprendere l’intero cielo visibile in appena pochi giorni.
Ma accendere una macchina del genere non è affare da poco. Le fasi attuali non riguardano più l’assemblaggio, bensì la messa in servizio, un processo delicato che prevede il raffreddamento dei sistemi elettronici e sensibili a temperature estremamente basse per garantirne la stabilità operativa.
Sotto zero per vedere l’Universo
Il cuore della fotocamera è il criostato, una camera che isola termicamente i componenti interni. «Il vuoto è essenziale per proteggere l’elettronica dai cambiamenti di temperatura», spiega Stuart Marshall, scienziato operativo della fotocamera e ricercatore senior presso SLAC. Una volta creato il vuoto, verrà attivato un circuito di refrigerazione che farà circolare un fluido a –50 °C, in grado di rimuovere il chilowatt di calore generato dal sistema elettronico. L’obiettivo è mantenere le componenti tra i –20 e –5 °C, mentre i sensori CCD richiedono un raffreddamento ancora più estremo, fino a –100 °C, per garantire immagini prive di rumore termico.
Lavoro di squadra tra scienza e ingegneria

Le operazioni di messa in servizio sono condotte da un team internazionale altamente specializzato. Accanto a Marshall, anche la postdoc Yijung Kang di SLAC e Yousuke Utsumi, professore associato al National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ), stanno contribuendo a portare online il sistema. Tutti lavorano a cinque metri d’altezza, su una piattaforma limitata a 125 kg di carico, incastrati tra la fotocamera e lo specchio del telescopio.
«Ogni parte del sistema deve essere compresa a fondo», spiega Utsumi. «Il lavoro è complesso, ma il team è pronto ad affrontare anche gli imprevisti più difficili.»
Countdown verso la prima luce
Una volta stabilizzata la temperatura e attivati i CCD, il momento tanto atteso si avvicina: la rimozione del gigantesco copriobiettivo da 1,7 metri di diametro, che avverrà con l’aiuto di una gru. A quel punto, per la prima volta, la luce delle stelle raggiungerà i sensori LSST. Gli specialisti delle osservazioni sceglieranno la porzione di cielo da analizzare, e il telescopio catturerà le prime immagini.
Queste immagini, proiettate su tre schermi giganti nella sala di controllo, segneranno l’inizio di quella che è stata definita “la più grande pellicola astronomica mai realizzata”: un’indagine di dieci anni sull’Universo visibile, che genererà un time-lapse ad altissima risoluzione della volta celeste, utile a studiare transiti planetari, supernove, movimenti di galassie e persino a migliorare i modelli di cosmologia.
Un’eredità per la scienza del futuro
Il Legacy Survey of Space and Time (LSST) non sarà solo un catalogo di immagini: sarà una risorsa scientifica globale. I dati saranno resi pubblici e accessibili agli scienziati di tutto il mondo, permettendo di affrontare questioni fondamentali come la natura della materia oscura e l’espansione dell’universo. Il Rubin Observatory onora la memoria dell’astronoma Vera Rubin, pioniera nello studio delle curve di rotazione galattiche che per prima dimostrò l’esistenza della materia oscura.
Con la prima luce prevista per il 2025, il Rubin Observatory si prepara a diventare uno dei pilastri della nuova astronomia osservativa.
Approfondimenti e link utili
- Vera C. Rubin Observatory
- SLAC National Accelerator Laboratory
- NSF – National Science Foundation
- DOE – Office of Science
- NOIRLab – National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory