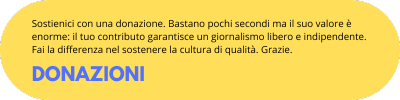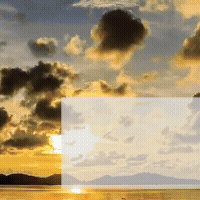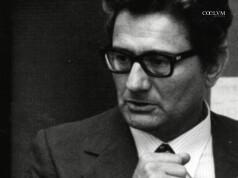Con l’approvazione definitiva al Senato l’11 giugno 2025, l’Italia compie un passo fondamentale nella direzione di una governance moderna, sovrana e competitiva delle proprie attività spaziali. La legge “Disposizioni in materia di economia dello spazio” (MES 1415) introduce, per la prima volta, un impianto normativo organico che regola autorizzazioni, responsabilità, controllo e sviluppo delle attività spaziali civili e commerciali. Una cornice giuridica che non solo colma un vuoto, ma che si inserisce in modo coerente nel panorama normativo internazionale ed europeo, affermando la volontà dell’Italia di giocare un ruolo da protagonista nella new space economy.
Le finalità della legge: sicurezza, innovazione e competitività
Fin dal primo articolo, il testo chiarisce l’intento strategico della norma: regolamentare l’accesso allo spazio extra-atmosferico per proteggere interessi economici, scientifici e di sicurezza nazionale, e contemporaneamente promuovere l’innovazione, lo sviluppo tecnologico e la valorizzazione delle competenze italiane nel settore.
Tra le attività considerate “spaziali” rientrano: il lancio e la gestione di oggetti in orbita, la rimozione di detriti, l’uso di piattaforme stratosferiche, l’estrazione di risorse da corpi celesti, la permanenza umana nello spazio e persino la produzione industriale in microgravità.
Autorizzazioni e vigilanza: una procedura strutturata e rigorosa
La legge stabilisce che ogni operatore, italiano o straniero, debba ottenere un’apposita autorizzazione per condurre attività spaziali sul territorio nazionale o sotto bandiera italiana. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso di requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
- idoneità tecnica e ambientale dei progetti,
- resilienza informatica,
- disponibilità di sistemi anti-collisione,
- copertura assicurativa obbligatoria fino a 100 milioni di euro.
Il ruolo di vigilanza è affidato all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che svolge anche funzione di regolatore tecnico, in sinergia con il Comitato Interministeriale per le Politiche Spaziali (COMINT).
Registro nazionale e responsabilità: tracciabilità e trasparenza
Ogni oggetto spaziale lanciato sotto giurisdizione italiana deve essere immatricolato in un Registro nazionale, gestito da ASI, in linea con la Convenzione ONU sull’immatricolazione degli oggetti spaziali (1975). È previsto anche un Registro complementare per i satelliti gestiti da operatori italiani ma registrati all’estero.
La responsabilità civile per eventuali danni causati da oggetti spaziali è in capo all’operatore, ma lo Stato può intervenire in caso di risarcimenti internazionali (come previsto dalla Convenzione sulla responsabilità per danni da oggetti spaziali del 1972), con possibilità di rivalsa sull’operatore privato.
Lo spazio come leva economica: fondi e pianificazione pluriennale
La legge introduce due strumenti centrali per lo sviluppo dell’economia spaziale nazionale:
- un Piano nazionale quinquennale per l’economia dello spazio, aggiornato ogni due anni dal COMINT in collaborazione con ASI e altri ministeri strategici;
- un Fondo per l’economia dello spazio, con una dotazione iniziale di 35 milioni di euro (2025), destinato a finanziare progetti innovativi, startup e PMI attraverso contributi diretti o operazioni finanziarie.
Compatibilità internazionale: la legge italiana si allinea alle convenzioni ONU e alla normativa UE
L’impianto normativo italiano è attentamente costruito per risultare compatibile con le principali convenzioni internazionali ratificate dall’Italia:
- Outer Space Treaty (1967): la legge italiana ne recepisce i principi di uso pacifico, responsabilità statale e giurisdizione nazionale.
- Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space (1975): la creazione del Registro nazionale risponde a obblighi formali previsti a livello ONU.
- Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972): la disciplina della responsabilità civile e del diritto di rivalsa è direttamente modellata su queste disposizioni.
Anche il rapporto con il quadro normativo europeo è pienamente rispettato. L’art. 27 esclude esplicitamente l’applicazione della legge italiana ai programmi spaziali europei già disciplinati dal Regolamento UE 2021/696 (Galileo, Copernicus, SSA, GOVSATCOM). Inoltre, la legge integra strumenti di finanziamento e sviluppo con quelli dell’Unione, come InvestEU, Horizon Europe e i fondi ESA, garantendo sinergia e interoperabilità con l’infrastruttura industriale europea.
Spazio e sovranità: infrastrutture strategiche e sicurezza nazionale
Particolarmente significativi sono gli articoli dedicati alla sicurezza:
- viene promossa una riserva nazionale di capacità trasmissiva satellitare, per assicurare le comunicazioni governative anche in caso di blackout delle reti terrestri;
- si sostiene l’uso strategico dei dati spaziali per la prevenzione dei rischi ambientali e il monitoraggio climatico;
- si promuovono iniziative per l’uso efficiente dello spettro radioelettrico, in previsione dell’esplosione del traffico spaziale nei prossimi anni.
Una legge moderna per un settore in espansione
Con questo testo normativo, l’Italia si allinea finalmente ai Paesi che già da tempo hanno adottato leggi quadro per l’attività spaziale, come Francia, Lussemburgo e Germania. In particolare, la scelta di dare centralità all’ASI e di puntare su partenariati pubblico-privati rende la norma compatibile sia con le esigenze del mercato che con la necessaria tutela degli interessi pubblici.
Conclusione
La legge “MES 1415” non è solo un atto legislativo: è una dichiarazione d’intenti. Riconosce lo spazio come nuovo dominio strategico e industriale, e ne affida la gestione a una governance multilivello, dove Stato, imprese, ricerca e istituzioni collaborano per garantire innovazione, sicurezza e sovranità.
Sarà ora compito dei decreti attuativi e della politica industriale nazionale trasformare questo impianto giuridico in un’effettiva leva di sviluppo economico e geopolitico. Lo spazio, anche per l’Italia, è sempre meno solo un orizzonte e sempre più un campo d’azione.
Il testo completo è disponibile a questo LINK